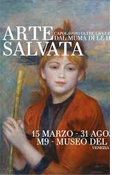|
|
A Mestre, la mostra «Arte salvata» da Le Havre
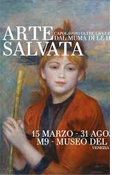 La mostra durerà dal 15 marzo al 31 agosto ed è stata organizzata per ricordare gli ottanti anni dalla fine della Seconda guerra mondiale che rase al suolo nel settembre 1944 la città di Le Havre, che fu ricostruita intorno al suo museo, il MuMa, come simbolo della ripresa post-bellica. Nella stessa maniera Mestre e Marghera subirono un bombardamento pesante che rase al suolo gli impianti industriali della città di Venezia. Anche in questo caso la rinascita della città avviene similarmente a Le Havre con tenacia e determinazione. Due città martoriate dalla guerra, dai bombardamenti e dalla furia del tempo. Due scrigni del patrimonio universale che s’incontrano al museo M 9 di Mestre per dialogare in un tempo che della guerra risente fortissimo i segnali d’allarme. Nello stesso tempo la mostra inaugura un nuovo dialogo internazionale per l’istituzione veneziana, dopo le esposizioni dedicate a Banksy e Burtynsky, accogliendo 51 opere provenienti dal Museo d’Arte Moderna André Malraux di Le Havre (MuMa), una delle più significative collezioni impressioniste di Francia. Sessant’anni dopo, la città di Le Havre ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO, suggellando la continuità tra passato e futuro. La mostra durerà dal 15 marzo al 31 agosto ed è stata organizzata per ricordare gli ottanti anni dalla fine della Seconda guerra mondiale che rase al suolo nel settembre 1944 la città di Le Havre, che fu ricostruita intorno al suo museo, il MuMa, come simbolo della ripresa post-bellica. Nella stessa maniera Mestre e Marghera subirono un bombardamento pesante che rase al suolo gli impianti industriali della città di Venezia. Anche in questo caso la rinascita della città avviene similarmente a Le Havre con tenacia e determinazione. Due città martoriate dalla guerra, dai bombardamenti e dalla furia del tempo. Due scrigni del patrimonio universale che s’incontrano al museo M 9 di Mestre per dialogare in un tempo che della guerra risente fortissimo i segnali d’allarme. Nello stesso tempo la mostra inaugura un nuovo dialogo internazionale per l’istituzione veneziana, dopo le esposizioni dedicate a Banksy e Burtynsky, accogliendo 51 opere provenienti dal Museo d’Arte Moderna André Malraux di Le Havre (MuMa), una delle più significative collezioni impressioniste di Francia. Sessant’anni dopo, la città di Le Havre ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO, suggellando la continuità tra passato e futuro.
La mostra è stata curata da Marianne Mathieu, una delle maggiori esperte mondiali di impressionismo e post-impressionismo, e da Geraldine Lefebvre, Direttrice del MuMa e presenta 51 capolavori della pittura dell’Ottocento e del primo Novecento che sono sopravvissuti ai bombardamenti e sono opere di Renoir, Monet, Sisley, Gauguin, Dufy, Marquet, Boudin e Braque.
Guardando queste meraviglie si capisce l’importanza del patrimonio culturale e del ruolo che esso gioca nel mantenere viva la memoria collettiva, il valore dell’arte come veicolo di resilienza e di rinascita. Diceva Reynold Arnould, primo direttore del MuMa: «Il museo è una costruzione vivente all’interno della quale i visitatori possono muoversi in libertà, in ascolto dei propri sensi e assecondando i propri desideri».
Il dialogo tra le due città è messo in risalto all’inizio della mostra con una sezione dedicata a una testimonianza fotografica che illustra quanto accaduto a Mestre a partire dal terribile bombardamento del 28 marzo 1944, che prosegue mostrando il percorso di risanamento iniziato nel secondo dopoguerra del patrimonio abitativo e quello della zona industriale. L’immagine del Museo-Biblioteca di Le Havre del 1860 di Edouard Fortin è messa accanto alla fotografia di Marcel Maillard del 1944 dopo i bombardamenti. Ne esce fuori un corpo architettonico mutilato, un brandello come direbbe Giuseppe Ungaretti, in San Martino sul Carso: È il mio cuore il paese più straziato. Ci solleviamo con la fotografia del 1960 di M. Barel del Museo MuMa – Museo d’arte moderna André Malraux che simboleggia il trionfo del modernismo sulle ferite della guerra. Similarmente, a Mestre una foto dell’archivio Cameraphoto Epoche di Vittorio Pavan ci fa vedere Lungo il viale San Marco che costeggia il Villaggio come un emblema del Neorealismo italiano. Un signore dal capello tirato in testa spinge sulla strada una bici carica di cianfrusaglie. Nello sfondo i palazzoni del nuovo quartiere come delle torri della nuova modernità solitarie, piantate lì con il loro bel viale deserto, segno del sofferto passaggio dalla guerra al boom degli anni ‘50 e ’60. Vecchio e nuovo cozzano un po’ anche nella veduta dell’Archivio Resini foto di Borlui Mestre, il Villaggio San Marco in via di ultimazione. Le due città di mare – Venezia e Le Havre sembrano identiche nelle vedute aeree del dopoguerra, con vialoni geometrici, con costruzioni moderne, con la voglia di vivere di chi è sopravvissuto alla distruzione bellica.
Ed ecco un altro motto di Reynold Arnould: «Lo scopo del museo è accogliere i pubblici, compresi i meno esperti, per scoprire l’arte, per favorirne non una conoscenza fattuale, ma un incontro intimo e sensibile». Pensando al Museo M 9 di Mestre le parole calzano a pennello.
André Malraux, ministro della cultura del dopoguerra, affermava con orgoglio del museo di Le Havre: «Nonc’è una casa come questa al mondo. Ricordate, gente di Le Havre, si dirà che è qui che tutto è cominciato». I dipinti raccontano l’evoluzione artistica di Le Havre, punto centrale del patrimonio della città intorno al quale si ri-costruisce l’identità. Il museo è stato fondato nel 1845, in piena rivoluzione industriale e ha visto crescere la sua collezione grazie all’impegno di pittori, mecenati e collezionisti che hanno trasformato Le Havre in un centro di modernità all’avanguardia. Le opere appartengono ad artisti locali e internazionali, partendo da quelle di Eugène Boudin e del suo allievo Claude Monet. A loro si aggiungono impressionisti come Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Maxime Maufra e Henry Moret, simbolisti come Paul Gauguin, Jean-Francis Auburtin, Ker Xavier Roussel, Maurice Denis e Marie Droppe. Le Havre è la patria della nascita del Fauvismo di Raoul Dufy e Othon Friesz, che a loro volta si ispirano alla luce meridionale di Albert Marquet e Charles Camoin.
La prima tela che ci accoglie è L’escursionista di Perre-Auguste Renoir, un’opera del 1888 circa, lascito testamentale di Charles-Auguste Marande del 1936. Bella con la ciocca dei capelli al vento, con un bastone da passeggio impugnato nella mano ci guarda la giovane donna allegra. Un nastro gli raccoglie i capelli color rame come per darci l’impressione della pittura en plain air.
Segue un’opera di Claude Monet Le scogliere di Varengeville del 1897, donazione dell’artista del 1910. Si tratta della costa della Normandia dove il pittore aveva lavorato da giovane e dove ritorna. L’opera è un insieme di macchie di colori tenui con rilievi topografici evanescenti con tocchi di bianco a rappresentare le vele bianche delle imbarcazioni al largo. L’influenza delle stampe giapponesi è evidente.
Jean-Francis Auburtin dipinge Varengeville, la casa dei doganieri nel 1922 e il quadro fu acquistato dalla città nel 2016. La mia mente vola ai versi di Eugenio Montale e alla sua Casa dei Doganieri:
Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t’attende dalla sera
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto.
Lucien Hector Monod è presente con una meravigliosa Silhouettes prima dell’alba del 1892, acquisto della città di Le Havre dello stesso anno. Allievo di Puvis de Chavanne, marito della principessa romena Maria Cantacuzino, ed ecco come il cerchio si chiude. L’intellighenzia internazionale si dà la mano. Il quadro è poetico con la sua luce fredda di una mattina d’inverno e la silouhette di una giovane donna che scruta il mare per vedere la barca del pescatore a lei legato. Viene ritratta di spalle, senza un volto, solo il sentimento, l’attesa come soggetto dell’opera.
Claude Monet sorprende con un Sole d’inverno, Lavacourt del 1979-1880, lascito di Charles-Auguste Marande del 1936. Quell’inverno fu rigido e le temperature basse ghiacciarono la Senna. In questo quadro il «freddo sole» come direbbe Giovanni Pascoli nel suo Novembre è sola macchia di colore in un universo grigio di cielo e acqua ghiacciata riportato con due colori essenziali nonché complementari: l’arancione e il blu. Tocchi rapidi di una pennellata veloce come il verso di un haiku, sentimento puro sospeso nell’area fredda d’inverno.
Sempre di Monet è anche La Senna a Vétheuil del 1878, collezione Oliver Senn, donazione di Hélène Senn-Foulds del 2004. Una testimonianza del viaggio dettato dalle difficoltà finanziarie del pittore che lascia Parigi per affittare a Vétheuil una casa e dove lo insegue la tristezza per la preoccupazione della salute della moglie Camille. L’opera è un’ammirabile simmetria di piani orizzontali e verticali e rappresenta una mattinata sull’isola di Moisson. Gli alberi sembrano mossi del vento sotto le pennellate piccole e intense di Claude Monet.
Non poteva mancare Alfred Sisley con la sua opera La Senna a Pont-du-Jour del 1877, donazione di Pieter van der Velde del 1912. Un inglese a Parigi, nato da genitori per l’appunto inglesi e ammiratore di Turner e Constable. Qui rappresenta la Senna nella zona sinistra del fiume dove oltre la natura appare la ciminiera della rivoluzione industriale come punto focale del quadro. Il cielo è pieno di nuvole che a loro volta si riflettono sulla Senna. Il vento fa volare i batuffoli di nuvole come in una ripresa cinematografica.
L’esperienza visiva è piacevolmente accompagnata da un fondo musicale a cura di Dario Falcone, giovane musicista veneziano. Debussy, Ravel, Messiaen, Malipiero, ma anche Bach, Mozart e Chopin – questi ultimi particolarmente amati da Dufy, cui dedicherà diversi omaggi pittorici – aiuteranno i visitatori a immergersi nella temperie culturale di inizio Novecento. Era abitudine a quel tempo il binomio formato da un musicista e un artista. Erik Satie, per esempio, era amico di Costantin Brâncuși e la sua Gnossienne n. 1 sa molto anche di una ballata (doina) dell’Oltenia da dove proveniva lo scultore romeno e che sicuramente faceva ascoltare la sua musica dell’infanzia romena al compositore e amico francese.
Nella prima sala della mostra al M9 Orizzonti, per tutta la durata della mostra viene proiettata ESCALATION >< INVOLUTION, la video installazione dell’artista trevigiano Alessandro Zannier, supportata da OOM (Alex Piacentini e Nicholas Bertini). Le immagini e i dati statistici dimostrano il legame tra l’impoverimento culturale e l’aumento dei danni ambientali. L’opera dialoga con la mostra Arte Salvata e illustra le perdite subite dal patrimonio artistico e storico mondiale nei secoli ad opera dell’uomo. Parallelamente, il secondo e il terzo piano del Museo ospitano una sezione fotografica dedicata alla guerra a Mestre, con particolare attenzione al bombardamento del 28 marzo 1944, che provocò la morte di circa duecento persone. Le immagini documentano la devastazione, l’esodo della popolazione e le difficili condizioni della ricostruzione post-bellica.
La cosa inedita di questa mostra è stato il programma di incontri per approfondire la memoria che ha accompagnato l’Arte salvata con un public program interdisciplinare. Tra gli appuntamenti, l’intervento del giornalista Salvatore Giannella del 26 marzo che ha raccontato le storie di chi ha salvato il patrimonio artistico italiano durante la guerra, la conferenza dello storico Lorenzo Benadusi del 12 aprile sulla rottura dei paradigmi culturali tra Ottocento e Novecento. Il 24 aprile, Dario Falcone ha parlato delle connessioni tra arte e musica nel primo Novecento, il 21 maggio Laura Mariani e Carlotta Sorba si sono soffermate sul ruolo delle attrici teatrali tra i due secoli. La rassegna si è conclusa il 5 giugno con un incontro dedicato alla storia di Mestre e Marghera durante il conflitto.
L’esposizione è stata realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Sponsor e con il contributo di Duferco Energia, Edison, la Camera di Commercio Venezia Rovigo e Generali – Agenzia di Venezia San Marco, si avvale della media partnership di Rai Radio 3 e Rai Cultura. Un evento che esalta la capacità dell’arte di diventare memoria condivisa e forza di rinascita, testimoniando come la cultura possa essere il fulcro di una nuova costruzione del presente.
Una mostra imperdibile questa Arte salvata, testimonianza della sopravvivenza alla Seconda guerra mondiale in Francia a Le Havre come in Italia a Venezia. Città d’acqua e di vita unite da un destino comune – la Rinascita.
Per la Francia, Le Havre è la patria dell’impressionismo e del fauvismo, per l’Italia, Mestre è il polmone industriale di Venezia, la sua modernità.
Ma la cosa che ci rimane come insegnamento di vita e non soltanto culturale è che il museo della città – MuMa come M9 – sono punti della memoria e della costruzione dell’identità. Proprio per questa loro dimensione formativa i due templi della cultura devono essere salvati dalla distruzione del tempo divoratore per finire con una verso di un sonetto di William Shakespeare:
Tempo divoratore, spunta gli artigli al leone,
E fa’ che la terra divori la sua dolce progenie,
Strappa le zanne aguzze alle fauci crudeli del tigre,
E ardi nel suo sangue la fenice imperitura.
Il tempo divoratore aveva rovinato il Museo della città di Le Havre, ma la gente l’ha ricostruito e ha messo prima in salvo le sue opere, ha distrutto Mestre con i stessi bombardamenti della Seconda guerra, ma la città è stata ricostruita dalle fondamenta. Lo stesso tempo divoratore erode la città di Venezia, ma il Mosè la difende dall’acqua della laguna. Nella terra ferma, a Mestre, la città di Venezia conserva la sua modernità in un museo che si chiama M9 e che occupa non solo lo spazio centrale del posto, ma anche l’anima forte di questo popolo veneziano eroico nella Resistenza e al bombardamento e che oggi si rispecchia nella sua identità con un museo che è un fiore all’occhiello della città di Mestre e di Venezia tutta.
Per maggiori informazioni potete consultare il link: https://www.m9museum.it/mostre/arte-salvata-capolavori-muma-le-havre
Liana Corina Țucu
(n. 7-8, luglio-agosto 2025 anno XV)
|
|